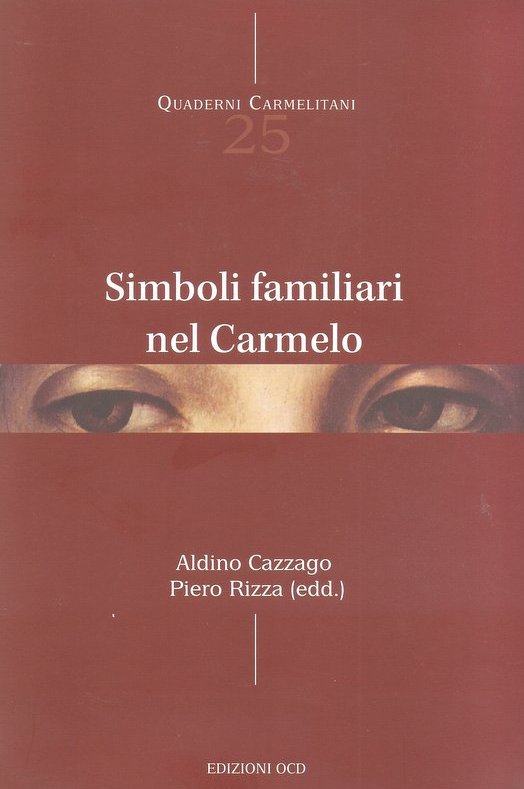di P. Antonio Maria Sicari ocd
MISERICORDIA PER GLI ULTIMI
 1. San Vincenzo de’ Paoli (1581-1660).
1. San Vincenzo de’ Paoli (1581-1660).
Nel suo secolo e nella sua patria, Vincenzo era il Santo che scopriva continuamente nuovi poveri e nuove miserie, pensando che il Signore chiamasse proprio lui a prendersene cura, tanto che è a tutti noto come «il santo delle carità».Fu lui ad aprire alle donne (di solito destinate al chiostro) anche il «monastero del mondo». Sono celebri – per il cambiamento epocale che esse significarono – le parole con cui Vincenzo delineò la nuova “forma di vita” per le sue “suore di Carità”: «Esse avranno per monastero le case degli ammalati e quella dove risiede la superiora. Per cella, una camera d’affitto. Per cappella, la chiesa parrocchiale. Per chiostro, le strade della città. Per clausura, l’obbedienza. Per grata, il timor di Dio. Per velo, la santa modestia. Per professione, la confidenza costante nella divina Provvidenza e l’offerta di tutto il loro essere».
E a quelle tra loro che si occupavano dei bambini abbandonati (una vera piaga sociale del suo tempo) dava questa educazione, splendente come l’oro: «Somiglierete alla Madonna, perché sarete madri e vergini al tempo stesso. Vedete, figlie mie, quel che ha fatto Dio per voi e per loro? Sin dall’eternità ha stabilito questo tempo per ispirare ad alcune signore il desiderio di prendersi cura di questi piccini che Egli considera suoi: sin dall’eternità ha scelto voi, figlie mie, per servirli. Che onore è questo per voi!».
E poiché, nel cuore e nella mente di Vincenzo, le opere e le iniziative si moltiplicavano, tanto quanto si moltiplicavano le urgenze che egli incontrava sulla sua strada (i malati abbandonati, gli anziani senza famiglia, i mendicanti, i galeotti, e così via), egli aveva preso l’abitudine di spiegare alle sue suore che ogni nuova opera era appunto la maniera con cui Dio le ricompensava dell’incarico precedentemente assunto. E fu con questa “logica” (per lui evidentissima!) che abbracciò e praticò tutte le opere di misericordia, necessarie alla società del suo tempo.
Quando decise di assumersi anche la cura dei dementi, spiegò estasiato alle sue suore: «Ah, sorelle mie, ve lo dico ancora una volta, non c’è stata mai una compagnia che debba lodare Dio più della nostra! Ce n’è forse qualcuna che si occupa dei poveri pazzi? No, non ce n’è nessuna. Ed ecco che questa fortuna tocca a voi! Oh, figlie mie, quanto dovete essere grate a Dio!». Ma, giustamente, H. Brémond, il grande storico della spiritualità cristiana, annotava: “Non è l’amore per gli uomini che ha condotto Vincenzo alla santità, ma piuttosto la santità, che l’ha reso veramente ed efficacemente caritatevole; non sono i poveri ad averlo donato a Dio, ma è Dio, al contrario, che l’ha donato ai poveri”»1.
La vera carità, infatti, nasce dallo sguardo che non si distrae mai, nemmeno per un attimo, dall’essere proteso a Gesù vivo, riconosciuto, amato, tanto che Vincenzo insisteva sempre: «Il fine principale per il quale Dio ci ha chiamati è per amare Nostro Signore Gesù Cristo. Se ci allontaniamo anche di poco dal pensiero che i poveri sono le membra di Gesù Cristo, infallibilmente diminuiranno in noi la dolcezza e la carità». E il suo biografo racconta che l’ultima parola da lui pronunciata sul letto di morte fu proprio questa: «Gesù!».
***
2. San Damiano de Veuster (1840-1889).
Nel 1865 a Molokai – un promontorio roccioso e spoglio delle isole Hawaii – fu realizzata un’orribile colonia di lebbrosi, ritenuti allora incurabili e, perciò, destinati a un totale e perpetuo isolamento. L’isola era chiamata «l’inferno dei vivi», o anche «il cimitero dei viventi», dove non esisteva alcuna legge o umana solidarietà. Ogni mese giungeva una nave, dalla quale sbarcavano nuovi malati, requisiti a forza.
Lo si sarebbe detto un luogo in cui non era più possibile alcuna misericordia; se i corpi si disfacevano nella più totale mancanza d’igiene (neppure l’acqua era garantita!), le anime si disfacevano nella più totale corruzione: schiavizzazione sessuale di donne e bambini, abusi di ogni genere, alcoolismo e droghe, latrocinio generalizzato, pratiche idolatriche e superstiziose. Così fu per otto anni. Poi sbarcò volontariamente nell’isola il primo uomo bianco deciso ad abitare santamente quell’inferno: padre Damiamo de Veuster. Si trovò così a vivere tra circa ottocento «intoccabili» (tali erano considerati i lebbrosi) e per il missionario si pose subito la questione radicale: annunciare la misericordiosa Incarnazione del Figlio di Dio.
Per farlo in maniera credibile, toccare quei corpi malati e ripugnanti era la prima forma di evangelizzazione! Erano “evangelizzazione” toccare le bocche rose dal male per deporvi l'ostia consacrata; ungere con l'olio santo mani e piedi cancrenosi, o bendare con tenerezza quelle orribili piaghe; lasciare che i bambini gli si gettassero in braccio e lo accarezzassero con i loro moncherini; mangiare a tavola il "poi" (carne mescolata con farina di taro) intingendo le mani, assieme ai lebbrosi, nel piatto comune; bere nelle tazze che gli venivano offerte; passare la propria pipa a chi gliela chiedeva.
Padre Damiano non agiva così solo per rispettare la sensibilità degli hawaiani, e quella ancora più acuta dei malati, ma per rispettare, per così dire, "la sensibilità della Chiesa": essa è per definizione "Corpo di Cristo"; tutti i suoi sacramenti e le sue opere sono segni di un "contatto fisico", salvifico, tra l'Umanità di Cristo e la nostra sofferente umanità. Se quel desiderato "contatto" era per gli hawaiani una questione culturale, per P. Damiano era anche una questione di fede. Innumerevoli furono le opere di misericordia compiute da questo «apostolo dei lebbrosi», ma – se si vuole scegliere e raccontare la più significativa ed efficace – bisogna ricordare proprio quella che di solito non richiede ai cristiani una pratica urgente né frequente, e che il catechismo formula così: «seppellire i morti».
A Molokai non c'era cosa più umana da fare, dato che impossibili e inutili erano le cure; certa era invece la morte. Così P. Damiano decise di invertire il solito iter che si usa in pedagogia. Se per tutti gli altri cristiani era importante imparare «a vivere bene per poter morire bene», per i lebbrosi di Molokai era necessario «imparare a morire bene per poter vivere bene». Se si pensa che, fino al suo al suo arrivo, i cadaveri venivano abbandonati all'aperto e dati in pasto ai maiali, si può capire l’impatto che ebbe la decisione del Missionario di “celebrare la morte”, dandole piena dignità umana. I lebbrosi venivano allora chiamati «i morti viventi» e il governo stava per varare una legge per dichiarali «legalmente morti». Perciò nell’isola la morte dominava, con tutto il suo corredo di brutture e turpitudini.
Con santa intelligenza P. Damiano intuì che doveva cominciare col rendere sacra la morte, impregnandola della fede cristiana nella risurrezione. Costruì, perciò, un bellissimo cimitero, proprio vicino alla sua capanna e fondò la confraternita dei funerali, che si dedicava a confezionare le bare di legno e ad accompagnare, pregando, il defunto all’ultima dimora, al suono della musica e al ritmo dei tamburi. Era una cerimonia che si verificava almeno tre volte la settimana, e che richiamava tutti al silenzio e alla preghiera e non più alle rabbie e alle ubriachezze, a cui si erano abituati.
In seguito gli fu più facile organizzare gli isolani in diverse altre confraternite per sovvenire alle più rilevanti necessità: quella per la cura dei bambini abbandonati, quella per l'educazione delle ragazze; quella per le visite ai malati; quella per la costruzione di chiese e abitazioni, o per la manutenzione delle capanne. Di fatto le varie "confraternite" (tutte dedicate a qualche Santo o a qualche mistero della fede cristiana) divennero anche delle strutture di convivenza civile e di assistenza sociale che nessun altro aveva saputo neanche immaginare.
All’occasione lo stesso P. Damiano diventava progettista, architetto, sterratore, muratore, carpentiere... e negli anni intraprese la costruzione di piccole scuole, dispensari, ambulatori, acquedotti e serbatoi. Per una logica profonda – che solo un santo può subito afferrare – la seconda, grande opera di misericordia messa in atto da P. Damiano fu la solenne celebrazione della festa del Corpus Domini, che divenne la festa più bella e commovente dell’isola, con esecuzioni musicali di grande bellezza. Riuscì, perfino, a introdurre la pratica dell’Adorazione perpetua: i turni e gli orari, di giorno e di notte, non era facile osservarli; ma quando un "adoratore" non poteva occupare il suo posto in chiesa, s’inginocchiava a pregare sul suo giaciglio.
Quando, alla fine, anche Padre Damiano si ammalò di lebbra e vide che il suo corpo cominciava a corrompersi (anche se non aveva ancora cinquant’anni) scrisse umilmente ai suoi superiori: «Sono diventato lebbroso. Penso che non tarderò a essere sfigurato. Non avendo alcun dubbio sul vero carattere della mia malattia, io resto calmo, rassegnato e felicissimo in mezzo al mio popolo. Il Buon Dio sa bene ciò che vi è di meglio per la mia santificazione, e ogni volta ripeto con tutto il cuore: Sia fatta la tua volontà!». Da allora, quando usava l’espressione «le mie membra malate» pareva che parlasse contemporaneamente sia dei suoi arti sofferenti, sia dei malati di quella sua comunità che cristianamente considerava «come Corpo di Cristo, e suo corpo».
***
 3. Beata Madre Teresa di Calcutta (1910-1997).
3. Beata Madre Teresa di Calcutta (1910-1997).
A intrecciare assieme il culto dell’Eucaristia e le opere di misericordia, si è dedicata anche la beata Madre Teresa di Calcutta. Aveva inaugurato la sua difficile missione con questa preghiera che era già tutto un programma: «Dio mio... non voglio fare marcia indietro. La mia comunità sono i poveri. La loro sicurezza è la mia. La loro salute è la mia salute. Il mio tetto è quello dei poveri. Non dei semplici poveri, ma di quelli che sono i più poveri tra i poveri. Di quelli ai quali si cerca di non avvicinarsi per paura di venir contagiati, di sporcarsi... Di quelli che non vanno in chiesa perché non hanno abiti da mettersi addosso. Di quelli che non mangiano perché hanno perduto le loro forze. Di quelli che stramazzano per le strade sapendo che stanno per morire, mentre i vivi gli passano accanto ignorandoli. Di quelli che non sono più capaci di piangere perché non hanno più lacrime».
Ma dove avrebbe trovato il segreto e la forza per dare un vero abbraccio di dolcissima carità a ogni emarginato? In seguito lei lo spiegherà così alle sue figlie: «Avete visto con quanto amore e delicatezza il sacerdote tratta il corpo di Cristo, durante la Messa? Cercate di fare lo stesso nella casa [dei morenti] dove state per andare: là c’è Gesù sotto le sembianze del dolore».E molte di loro avrebbero raccontato di non aver capito mai così bene quell’espressione eucaristica che parla di «presenza reale di Gesù», come toccando le membra dolenti dei malati.
Ed era proprio in forza di questa sublime «identificazione eucaristica» che Madre Teresa spiegava la reale identità del suo Istituto di carità: «Soprattutto noi siamo religiose, non assistenti sociali, non maestre, non infermiere, o dottoresse [...]. La differenza, tra noi e gli operatori sociali, sta in questo: che loro agiscono per qualcosa, noi invece agiamo per Qualcuno. Noi serviamo Gesù nei poveri. Tutto quel che facciamo – preghiera, lavoro, sacrifici – lo facciamo per Gesù. Le nostre vite non hanno alcun senso, alcuna motivazione all’infuori di Lui, che ci ama fino in fondo. Gesù solo è la spiegazione della nostra vita».
E «i più poveri dei poveri», di cui le sue suore si prendono cura ancor oggi, sono: i bambini non ancora nati, quelli malformati, i fanciulli abbandonati, le ragazze madri rifiutate dalla famiglia, i lebbrosi, le prostitute, i prigionieri, i barboni, gli alcolizzati, gli handicappati gravi, i malati mentali, le vittime delle varie guerre, i drogati, i malati di Aids, i moribondi. A chi le chiedeva informazioni più dettagliate sul suo programma e su come intendesse organizzare le sue «opere di misericordia», Madre Teresa rispondeva che aveva sempre di mira lo stesso inizio, lo stesso centro e lo stesso compimento. E li spiegava così:
- L’inizio: «Noi cominciamo sempre col pulire le latrine: cominciamo così ad aprire i cuori».
- Il centro: «Io amo Gesù con tutto il cuore e con tutto il mio essere. Gli ho dato tutto, anche i miei peccati, e Lui mi ha immersa nella tenerezza del suo amore. Adesso e per sempre io appartengo tutta al mio Sposo Crocifisso».
- Il compimento: «Lavorare per la santificazione dei poveri, per donare a Dio dei Santi...».
Ed è certo impressionante vedere una Santa che percepisce le opere di misericordia come capaci di segnare una strada percorribile (tutta dritta) che va dai luoghi più umili della terra fino ai gloriosi seggi del paradiso.
Note:
1 Citato da Giovanni Paolo II nella Omelia per i 250 anni dalla canonizzazione (27 settembre 1987).